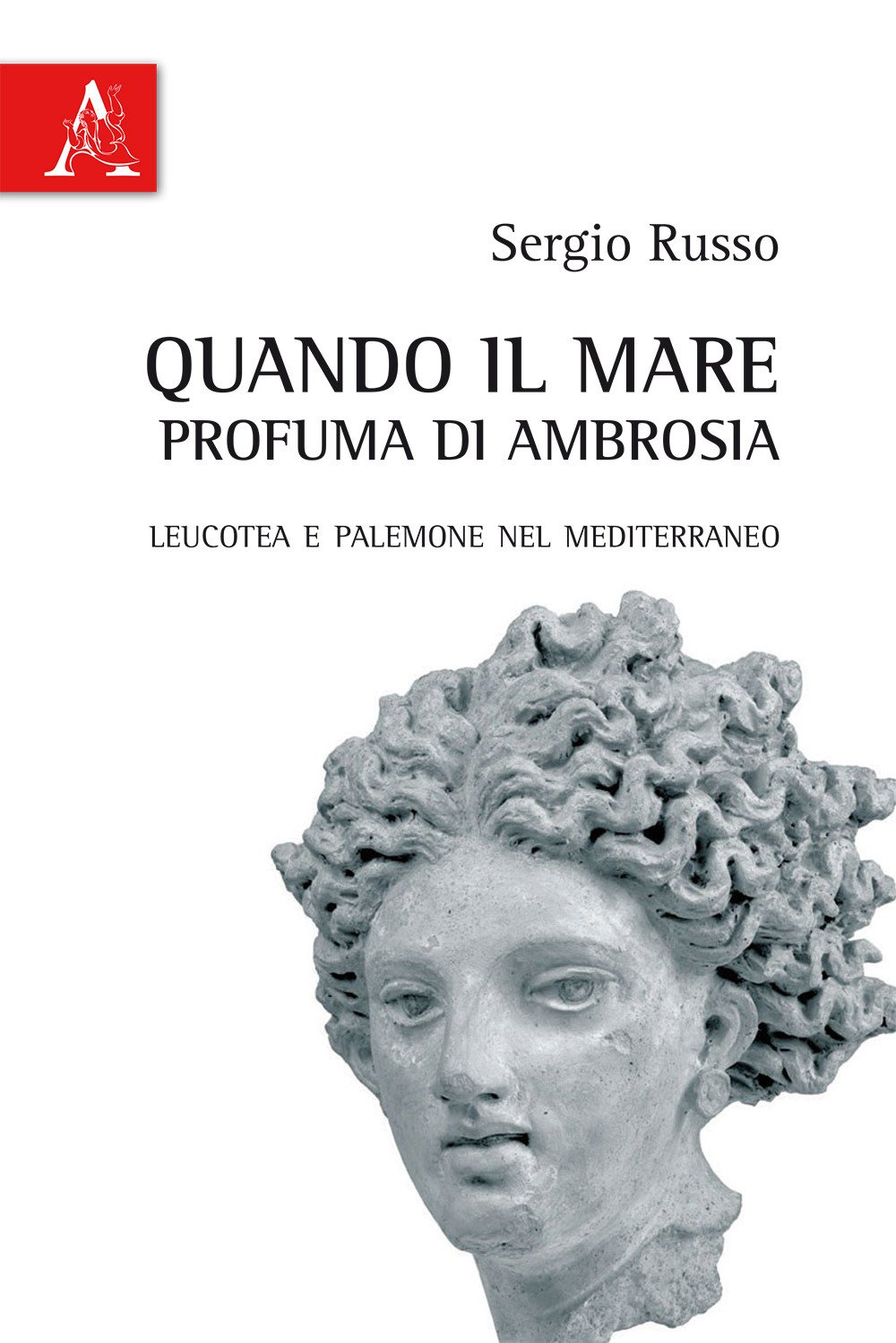Prima di rischiare di cedere a latenti tentazioni manichee, scriviamo subito la fine della recensione: “Il primo Re” è un buon film, che merita d’esser visto per una serie non piccola di pregi ed elementi di originalità e spessore che appresso tratteremo dettagliatamente. E’ fin troppo conosciuta l’insoddisfazione di ogni specialista di qualsivoglia materia, che si manifesta con irritazione nel momento in cui il cinema si occupa con grossolanità di un tema molto specifico a lui caro. Provate a chiedere ad un pugile cosa pensa delle scene più cruente di “Rocky”: riderà pensando male di chi abbia potuto scambiare quelle buffonate per un incontro di pugilato. Lo stesso vi diranno i poliziotti che assistono a filmati su indagini o cose simili. E’ il cinema, non è altro, ed in questo “luogo” la licenza poetica, narrativa, storica e di qualsiasi altro tipo, è legittima per consuetudine, per accordo fatto nell’ottocento, quando si decise di allargare i confini dell’immaginazione ben oltre i limiti imposti dal teatro.
Pagato quindi il debito con chi si lamenterà per una mancata stroncatura, o per la sua “sorella diversa”, la “magnificatio” senza se e senza ma, passiamo all’analisi dell’opera.
Il regista de “il Primo Re” si chiama Matteo Rovere, e se il buongiorno si vede dal mattino, e nulla accade per caso, e “nomen est omen”, allora chiamarsi come l’albero simbionte di Iuppiter Pater e richiamare forza e potenza nel proprio nome, ci ha confortati prima ancora di vedere il film. Non mancheranno infatti la furia guerriera, l’ardore, il coraggio ed il sacrificio, il “Fuoco” quale forma manifesta della presenza divina. Tutto ciò ci porterà ad una approvazione complessiva dell’opera e ad una sensazione positiva e per qualche tratto entusiasmante, non senza passare per qualche analisi critica.
Venendo alla pellicola, va condivisa e fortemente apprezzata la scelta dell’utilizzo del protolatino. Il fatto che non rappresenti una scelta originale, ma ispirata ai due precedenti di Mel Gibson con “La passione di Cristo” ed “Apocalypto”, non sottrae valore alla decisione presa. Sono tempi troppo bui per voler ammirare ed approvare solo eventi originali. Conviene attestarsi su quelli intelligenti.
La resa, complice in buona parte l’amore che proviamo per la lingua dei Padri e dei nostri studi, risulta eccellente. E’ stato peraltro piacevole riscontare che buona parte dei dialoghi risultava comprensibile, ed a volte solo il volume, in alcuni passaggi troppo basso, ha impedito che si potesse, in diverse occasioni, capire la lingua parlata per lunghi tratti.
In particolare la parola “Fuoco” più volte pronunciata, diversamente da “Ignis” del latino di epoca successiva arrivato sino a noi, viene pronunciata “Egni”, mostrando il legame ancora forte con la radice arcaia indoeuropea, evidenziando un’affinità con il sanscrito “Agni” che ci ricorda ancora una volta che la Patria Primordiale e l’origine comune dei figli degli Arya delle origini ancestrali non sono un dato mitico, ma una certezza ben assestata negli studi linguistici, religiosi ed antropologici.
Altro dato entusiasmante riguarda la scelta dei luoghi e la loro bellezza. Girata interamente nel Lazio, la pellicola trasmette fin dalla prima scena – bellissima e mozzafiato – la potenza effettiva dei posti scelti, il magnetismo rimasto intatto laddove è stata tutelata la natura ferina e vibrante delle nostra terra, precisa espressione di quella geografia sacra che fu una delle motivazioni per le quali Roma fu fondata lì, “proprio lì” e non altrove. Anche le scene più cupe, caratterizzate dal costante grigiore climatico o dalle ore notturne, scelta non casuale e certamente rimandante ad aspetti “interiori”, risultano “cariche” anche nelle paludi o nei boschi ostili, proprio per l’elemento energico inscindibile dai luoghi più incontaminati della Saturnia Tellus.
I personaggi, a partire ovviamente da Romolo e Remo – ottimamente interpretati – mostrano eccessivi tratti di un primitivismo che appare come una scelta precisa, tendente a dare il profilo desiderato e non certamente per ignoranza o trascuratezza ricostruttiva. Qui bisogna essere precisi: non sappiamo per quale motivo il regista abbia scelto la cifra titanica e vitalistica dell’intera vicenda, né perché il tutto dovesse essere così diverso dai costumi di quel periodo. Di sicuro l’elemento di primordialità del quale sono portatori tutti i personaggi, non era esistente in quei termini all’epoca dei fatti narrati, ed in ogni caso non in quelle forme così selvagge, prive dell’elemento “civile” che le stirpi di Albalonga e Troia possedevano ormai da secoli. Alcuni tratti, solo per qualche secondo, rimandano a “La guerra del fuoco” – ma si tratta di fuoco profano – di Jean Jacques Annaud, senza certamente sconfinare in richiami evoluzionistici come nell’opera citata, piuttosto insistendo su caratteri neolitici e marcatamente natufiani, che non sono l’unico elemento medio-orientale presente nell’opera.
La trattazione dei sacrifici umani, in larghissima parte fantasiosa, è ispirata ad un indirizzo antropologico noto, caratterizzato da elementi ispirati al riduzionismo epistemologico, e ci rimanda alle medesime considerazioni fatte in precedenza sul primitivismo. La sfera del sacro non è assente, ma si manifesta in modalità diverse dalla realtà dell’epoca, più surreale e onirica, potente ed immanente, ma con non poche pecche da rilevarsi nelle forme e nella sostanza, che a ben vedere si sarebbero potute facilmente evitare. Persiste, fortunatamente, un clima noumenico intenso e costante, ma naturalmente, vista l’impostazione, la presenza di forze invisibili che condizionano ogni cosa, si declina in forma coerente con il resto. Avviene così che la Vestale assiste, anzi presiede, i cruenti sacrifici derivanti dai duelli; soffia sul fuoco per alimentarlo, accende lei, con le proprie mani, il Fuoco del Dio (mai nominato o declinato durante tutto il film), e si produce in una lettura del fegato dell’animale sacrificato, incarnando un ruolo fortemente fantasioso ( e non è detto che sia un fatto negativo), culminato in una divinazione delle interiora, compito di altri sacerdozi, che si spinge fino a ricordarci le atmosfere tolkieniane della lettura dello specchio di Galadriel, in un afflato di fantasia che però non disturba e che possiamo ritenere coerente con l’impostazione generale.
La scelta di non nominare mai né Dei né Dee, appare il frutto di una precisa volontà, volta ad evitare l’approfondimento strettamente religioso e liturgico, che a ben vedere avrebbe potuto appesantire la narrazione, ma che in ogni caso sarebbe stato apprezzato dai puristi della Tradizione e dagli studiosi di religione e storia. E’ vero che non bisogna giudicare il periodo della fondazione come se si trattasse di Roma e della sua religione di molti secoli dopo, ma è attestato che Latini, Sabini ed altre popolazioni italiche utilizzavano precisi nomi e riferimenti in tutte le occasioni, rituali o meno. Da qui deriva, si presume, la decisione di usare la definizione di “Triplice Dea”, una dizione presente in pressoché tutte le Tradizioni indoeuropee, che però difficilmente rimaneva non declinata nei riti:
” loro ti chiamano Ecate,
dea dai molti nomi, Mene,
Artemide lanciatrice di dardi, Persefone,
Signora dei cervi, luce nel buio, dea dai tre suoni,
dea dalle tre teste, Selene dalle tre voci,
dea dal triplo volto, dea dal triplo collo,
dea delle tre vie, che tiene,
la fiamma perpetua in tre contenitori,
tu che offri la tripla via,
e che regni sulla tripla decade.»
Lo stesso principio viene applicato ad un Fuoco di un Dio che viene chiamato semplicemente così per tutto il film, senza che si mostri la volontà di superare le approssimazioni, che più correttamente dovremmo definire “orientamenti diversi”. “Dio” e nient’altro, evita l’approfondimento specialistico, ribadisce un principio generale che volutamente ignora la prassi rituale, dedicandosi piuttosto a trasmettere sensazioni, stati d’animo, idee generali che non hanno bisogno di ortodossie di nessun tipo. Che si sia d’accordo o meno, questo è quello che si percepisce in ordine alla volontà del regista, che non manca di dedicare attenzioni alle dimensioni sottili. Ciò si evidenzia attraverso l’attenzione alla vita del Fuoco del Dio ed alla sua Fiamma Perenne che tutti senza distinzione manifestano, consapevoli che la continuità visibile del Fuoco ha una importanza fondamentale. Non casualmente, l’evidenza dei differenti destini dei due Gemelli, viene sottolineata dal fatto che Romolo riesce a riaccendere il Fuoco laddove Remo credeva che fosse definitivamente spento.
A parte queste pregevoli aperture verso il sacro, l’idea generale del rapporto con gli Dei e generici spiriti, è caratterizzata da un timore non presente in queste forme nel mondo indoeuropeo e, segnatamente, italico, nel quale possiamo ragionevolmente presumere che la paura così mostrata fosse del tutto inesistente. La non corretta osservanza della prassi rituale, la mancanza dei sacrifici prescritti, potevano semmai produrre timori sulla possibile avversione degli Dei, ma i termini con i quali le paure si manifestano nel gruppo guidato da Remo, sono di tipo ossessivo e rimandanti semmai ad un’idea del divino timorosa tipicamente monolatrica e medio-orientale, piuttosto che all’attitudine eroico-sacrale delle stirpi indoeuropee, che non si sentirono mai “servitori e pecore” degli Dei propri, semmai uomini portatori del loro sangue e della loro natura attenti al rapporto con essi: la Pax Deorum, che non viene “istituita” solo a Roma, costituendo parte dell’immenso patrimonio sacrale di tutte le Tradizioni indoeuropee e non solo.
Molto bello il rapporto tra Romolo e Remo. Potente, intenso ed a tratti commovente il modo in cui, fin dalla prima scena, in perfetta simbiosi gemellare, i due fratelli mostrano maggior attenzione alla salvezza dell’altro piuttosto che a quella propria, cercando ripetutamente il proprio sacrificio per evitare la morte del gemello. Ci piace pensare che il lungo tratto durante il quale Remo porta sulle spalle Romolo gravemente ferito, sia un chiaro richiamo ad Enea ed Anchise. In fondo, la nostra storia, nasce attraverso questi archetipi e si sostiene ancora oggi, fragilmente ed attaccata da ogni parte, sull’eredità degli antenati e i legami di sangue.
Nonostante ciò, emerge con chiarezza la dicotomia Ordine-Caos inscritta nel loro destino. Remo, abbandonato a se stesso, cerca d’incarnare un ruolo che non gli è proprio, mancando dell’assialità e dell’equilibrio propri di un Re. Non casualmente i suoi limiti emergono in assenza del fratello più saggio e centrato, che prende il suo posto quando gli eventi lo permettono. Funzionale alla sceneggiatura ed essenziale nel susseguirsi degli eventi, l’atteggiamento pio di Romolo rispetto alla deviazione profana e nefasta di Remo, condannato alla solitudine prima ancora che alla morte. Maledire gli Dei e sfidarli lo porta al titanismo ed all’azione demonica, mentre il fratello predestinato alla fondazione rimane centrato e fedele alla devozione celeste.
L’aspetto sul quale, a malincuore, si devono esprimere le critiche più forti, riguarda l’epilogo riguardante la fondazione di Roma. Essa procede nella narrazione come un evento piuttosto casuale, determinato da fattori contingenti, sviluppatosi nell’arco di pochi giorni. Anche il riconoscimento di Remo quale Re, avviene secondo modalità eccessivamente primitive e non coerenti con precise consapevolezze sulla sacralità, ben presenti all’epoca dei fatti narrati. Il mito ci ricorda che le famiglie dei Patres vollero la fondazione consapevolmente e secondo un patto stretto tra stirpi e tribù, sotterrando i propri beni e ricordi, essendo ormai decisi ad essere non più etruschi, latini o sabini, bensì romani e nient’altro. Qui tutto diventa eccessivamente semplicistico, occasionale, realizzato con una soluzione che possiamo facilmente definire “affrettata”. Una fretta che sembra colpire anche le modalità con le quali Romolo uccide Remo. Più che la volontà di farsi uccidere, che potrebbe essere una chiave di lettura, sembra che il regista volesse trasmettere l’idea che, essendo “storico” e non alterabile l’esito del duello, tanto valeva non caricarlo di una enfasi inutile ai fini narrativi. Il fatto poi che, fino al giorno prima, Romolo fosse debilitato ed infermo per una ferita grave, toglie ulteriore credibilità all’ipotesi del duello del giorno successivo, quasi che il regista, in questo caso, si sia liberatoriamente affidato al mito per chiudere la sua storia.
La parte finale non poteva rimediare all’assenza degli elementi non presenti in tutto il film. Nei protagonisti non v’è italica ed etrusca dignitas, e le aperture profonde e simboliche che a volte sono espresse dai personaggi, appaiono piuttosto una “scoperta” che di volta in volta pervade l’animo degli stessi, piuttosto che il frutto di un lignaggio, un retaggio all’interno del quale la consapevolezza della regalità, del valore, delle sacre certezze, costituisce la base per la fondazione sacra di una città.
La fondazione ed il confine da non superare sono eccessivamente poveri di simboli e gesti rituali. Non v’è aratro, nè buoi, non c’è il sulcus primigenius e non vi sono sacerdoti pronti all’evento fondativo. Non vi sono gli etruschi, d’altronde non v’è nessun vero e proprio rito di fondazione, etrusco o meno. Ma forse proprio in questa scena si manifesta la cifra voluta dal regista, sicuramente in buona parte riuscita, anche se lascia una traccia dentro di noi il fatto che un nostro connazionale non abbia colto l’occasione per conferire la giusta solennità ed importanza ad un atto così fondamentale per la nostra storia. Romolo dichiara “questa città nasce dal sangue (sacrificio) di mio fratello”, manifestando la comprensione superiore per il sacrificio e per ciò che da esso scaturirà, ma purtroppo sembra che tutto sia accaduto casualmente e non per una potente volontà guerriera e sacerdotale che tale fondazione aveva fatto bramare e realizzare con consapevolezza e volontà, e non per una rocambolesca fuga per evitare la morte. Se fantasia doveva e poteva esserci, legittimamente, ebbene speravamo che essa si spingesse sul sentiero della volontà lucida oltre che della predestinazione, della solennità, della suggestione, della profondità e della bellezza formale, piuttosto che verso un primitivismo qui e là attraversato da spezzoni di intensità sacrale. Intensità, va detto, che tiene inchiodati alla poltrona senza nessuna pausa del ritmo narrativo.
Non è detto che una ricostruzione più aderente alle conoscenza storiche in nostro possesso avrebbe necessariamente dato un risultato migliore. Ma non possiamo evitare di pensare che Matteo Rovere sia stato influenzato, solo per alcuni aspetti e per di più marginali, da un pensiero di origine marxista ben radicato nella mente della maggioranza degli italiani e non solo: Roma fu fondata da pastori dalle fattezze primitive. Certo, la dimensione guerriera, la centralità della forza e dell’ardore, non è trascurata, essendo ben espressa nel complesso e nei singoli personaggi, ma qui emerge più una necessità di sopravvivenza che la consapevolezza di affermare qualcosa di superiore, che viene da lontano e costituisce patrimonio e lignaggio di sacerdoti e guerrieri italici. Il problema non è quindi la dicotomia primitivismo-civiltà, piuttosto dovremmo parlare di casualità contro disegno ordinato, di coincidenza contro volontà precisa. Posta così la questione, non è più importante che Rovere si sia attenuto ad una realtà storico-mitica piuttosto che alla sua libera interpretazione, e nessuna delle due doveva essere considerata come scelta migliore dell’altra.
In sintesi: Roma fu fondata convocando sacerdoti e futuri Patres, per accordo, piano stabilito, dandosi appuntamento, incarnando una precisa volontà, permettendo, attraverso il Rito fondativo, di chiedere ed ottenere la benevolenza divina. Roma non fu fondata per caso, per sfuggire alla cattura, per sottrarsi al proprio sacrificio e fondare il sacro cerchio con quattro pietre messe lì a casaccio a due metri dal Tevere.
Ma, come dicevamo, questo è solo un film, un film bello ed originale, e non si poteva pretendere che esso si facesse portatore di istanze che, altrove e con altri mezzi, vanno affermate con ben altri fini e certezze.
Non per questo “Il primo Re” risulta meno godibile sul piano del coinvolgimento che riesce a suscitare, complice una gradevole colonna sonora che esercita una presenza discreta e non debordante. Possiamo affermare con certezza che la fantasia non toglie nulla alla godibilità. D’altronde il buon Puccini, uno che di racconti intensi se ne intendeva, preferiva inventarsi personaggi più o meno reali di un Giappone lontano, piuttosto che affidare i suoi testi al suggestivo ma tendenzialmente retorico Gabriele D’annunzio. Meglio un romanzo o un saggio? La dottrina pura o la poesia? Differenti risposte a queste domande, produrranno esiti diversi in ordine alla quantità d’entusiasmo che “Il primo Re” riuscirà a trasmettere ad ognuno di noi.
In conclusione, esprimendo soddisfazione per la realizzazione dell’opera, rimandiamo il pensiero a quella cartina geografica che, espandendosi progressivamente, ci ricorda le nostre grandezze passate ed il ruolo centrale della nostra Patria per i destini dell’intero cosmo. Sarebbe bastata quell’ultima illustrazione per giustificare l’esistenza e la bellezza del film, ma per fortuna c’è tanto altro. Tutti al cinema quindi, la bilancia pende decisamente verso gli aspetti positivi, e poi, diciamocelo francamente, un film italiano, girato in Italia, che parla delle origini dell’Urbe e della Patria, non è cosa di tutti i giorni.
Marco Francesco De Marco (Francesco Di Marte).